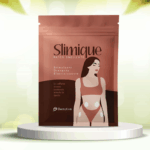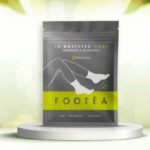Quando si parla di gioco d’azzardo in Italia è difficile quantificare con precisione quanto si spende davvero, poiché dietro le cifre ufficiali si nascondono costi spesso trascurati. Negli ultimi anni la tendenza non accenna a rallentare: secondo i dati più recenti, nel solo 2024 gli italiani hanno destinato al gioco una somma che supera i 157 miliardi di euro, una cifra colossale che risulta superiore persino a quelle investite nella sanità, nell’istruzione e nei bilanci di tutti i comuni messi insieme. Questa somma rappresenta però solo la punta dell’iceberg: gran parte di quello che effettivamente si perde non è palese e si annida tra perdite ripetute, illusioni di vincite e costi sociali indiretti.
La spesa reale: tra raccolta, vincite e veri costi
Quando si valuta la spesa effettiva nel gioco d’azzardo, si tende a confondere la raccolta (ossia il totale delle giocate) con il denaro effettivamente perso. Una parte di questo denaro viene, infatti, restituita in forma di vincite; il resto, invece, rappresenta la vera perdita dei giocatori. Ad esempio, nel 2021 la raccolta totale ammontava a circa 111 miliardi di euro, a fronte di una spesa effettiva – ovvero perdite nette dei giocatori – molto inferiore, anche se comunque impressionante. Nel gioco su rete fisica, ad esempio, la sola spesa registrata nel 2021 era di oltre 11,7 miliardi di euro; mentre per il gioco a distanza si parla di perdite superiori agli 8 miliardi nello stesso periodo.
Tuttavia, queste cifre non comprendono tutte le perdite mascherate. Molti giocatori procedono con nuove giocate grazie a piccole vincite, reinvestendole immediatamente e allungando la permanenza nel ciclo di gioco. Così, anche “recuperare” parte della cifra scommessa non costituisce un vero e proprio ritorno economico, ma piuttosto incentiva una perdita progressiva.
L’illusione delle vincite e il “valore atteso negativo”
Una delle più grandi verità nascoste riguarda il meccanismo conosciuto come valore atteso negativo. In termini semplici, ogni azzardo offre una probabilità di vincita strutturalmente inferiore a quella di perdita, con il risultato che, più si gioca, più si perde. Ad esempio, in giochi come le lotterie istantanee, la perdita attesa per ogni biglietto acquistato si aggira intorno a 1,47 euro su 5 spesi; su larga scala, l’erosione delle somme giocate diventa devastante. Questa dinamica è studiata proprio negli algoritmi di ogni forma di gioco, sia fisica sia online.
Molti giocatori sono convinti che la buona sorte possa invertire la loro situazione, magari investendo cifre sempre maggiori. Tuttavia, le vincite elevate sono rarissime e, anche nei casi in cui si ottengono somme importanti, spesso vengono reinvestite, alimentando un circolo vizioso. Nella realtà, solo pochissimi riescono a guadagnare nel lungo periodo, e mai cifre astronomiche; le storie di arricchimenti facili sono, di fatto, parte dell’immaginario e non riflettono la reale distribuzione dei benefici del gioco.
I costi nascosti: impatto sociale e personale
Dietro le cifre ufficiali si nascondono costi meno visibili, ma altrettanto, se non più, significativi. Tra questi, vi sono:
- Debiti personali in crescita: Molti individui finiscono per indebitarsi a causa del gioco, prosciugando risparmi, impegnando beni e rivolgendosi a prestiti formali e informali.
- Costi sociali e sanitari: L’aumento delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico comporta spese pubbliche ingenti sia per trattamenti sanitari sia per supporto psicologico, oltre a ricadute economiche sulle famiglie e sulle comunità.
- Perdita di produttività: Chi vive il malessere del gioco spesso subisce cali nelle prestazioni lavorative, con effetti dannosi sull’economia locale e nazionale.
- Crisi familiari e relazionali: La dipendenza da gioco minaccia la stabilità delle relazioni affettive, causando separazioni, incomprensioni e rotture anche insanabili.
Questi costi non sono direttamente quantificati nelle statistiche ufficiali, ma rappresentano una parte non trascurabile del bilancio reale legato al gioco d’azzardo.
Come cambiano le abitudini: l’ascesa dell’online e la difficoltà di controllo
Un fattore determinante nella crescita delle cifre perse nel gioco d’azzardo è l’espansione dei canali online. Con l’aumento dell’offerta digitale, l’accesso al gioco è diventato più semplice, frequente e discreto. Nel 2022, la raccolta totale delle giocate online in Italia ha superato i 67 miliardi di euro. Questa modalità comporta rischi aggiuntivi: l’anonimato, la rapidità di puntata e la facile reperibilità incentivano comportamenti impulsivi e compulsivi difficili da monitorare anche da parte degli organi di controllo.
Anche la tassazione statale, che storicamente traeva enormi benefici dal gioco fisico, oggi viene erosa dalla diffusione del gioco a distanza, caratterizzato da un prelievo fiscale molto più basso rispetto alle tradizionali macchinette e sale da gioco. Questo fenomeno implica una minore capacità dello Stato di reinvestire queste risorse in prevenzione e cura, aggravando il bilancio complessivo del fenomeno.
Perché le “vittorie” spesso non lo sono davvero
Un altro aspetto spesso sottovalutato consiste nella percezione distorta delle vincite. Molte persone celebrano piccole somme recuperate, senza rendersi conto che, statisticamente, ogni vincita è annullata da una serie di perdite precedenti o successive. È comune che chi si dedica regolarmente al gioco abbia l’impressione di essere “quasi in pareggio”, sottovalutando le vere cifre investite e perse nel tempo.
Inoltre, la natura psicologica del gioco porta molti a nascondere anche a sé stessi le cifre reali delle proprie perdite, complicando ulteriormente la possibilità di un’analisi lucida e razionale del fenomeno.
Prevenzione e consapevolezza: strumenti e prospettive future
Per contrastare la deriva delle perdite economiche e sociali legate al gioco d’azzardo, sono necessarie politiche pubbliche volte a rafforzare la prevenzione, migliorare la trasparenza dei dati e offrire strumenti di autoesclusione e formazione sui rischi. In questo ambito risulta fondamentale il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e dei media, affinché il fenomeno sia affrontato non solo come problema di singoli individui, ma come vera e propria questione sociale.
Sono inoltre utili sistemi di controllo dei limiti di spesa, supervisionati direttamente dai fornitori di servizi di gioco, insieme alla promozione di una cultura della consapevolezza finanziaria al fine di ridurre la fascinazione verso le false promesse dell’azzardo. L’attenzione pubblica e istituzionale dovrà necessariamente concentrarsi, nei prossimi anni, sulle strategie di prevenzione, nel tentativo di evitare che le cifre delle perdite continuino a crescere fino a livelli sempre meno sostenibili per la società.
Riconoscere l’entità reale di quanto si spende giocando d’azzardo non significa solo guardare ai numeri ufficiali, ma saper leggere anche i costi nascosti che incidono profondamente sulla vita delle persone, delle famiglie e dell’intera comunità.